«Si chiamava John Rambo ed era esattamente il tipo di ragazzo che tutti prima o poi hanno conosciuto di servizio alla pompa di benzina, su una strada come quella che portava al suo paese, Madison, nel Kentucky.»
Questo è l’esordio del romanzo First Blood (pubblicato all’uscita del film da Sperling in Italia) del 1972 di David Morrell, autore prolifico e ingiustamente dimenticato.
Tra gli eroi d’azione del cinema degli anni ’80 forse Rambo è il personaggio più amato e al contempo odiato dal pubblico. Di fatto è diventato un termine di paragone con cui tutti i protagonisti di storie d’azione dei tempi moderni devono confrontarsi. Per noi, che allora eravamo ragazzi e sognavamo l’avventura violenta e virile senza troppo stare a ragionare sulle ideologie politiche, fu una ventata d’aria fresca. Un personaggio muscolare, popolare in ogni senso del termine, “uno di noi” che si era trovato in una situazione estrema per il suo paese ed era stato trasformato in una macchina per combattere che lo aveva sconvolto. Uno che rifletteva il malessere dei reduci al ritorno in patria dopo una guerra che era stata vinta sul campo ma persa sotto il profilo diplomatico, sabotata da burocrazie e da fronti interni.
Un personaggio che, invece, per noi ragazzi italiani, era lo specchio di un’età incerta dove l’energia e l’entusiasmo giovanili si scontravano con un mondo di compromessi, che non capiva e imponeva regole contro cui la reazione violenta di Rambo ai soprusi dello sceriffo Teasle e dei suoi sgherri, sembrava l’unica soluzione possibile. Rambo, con il capello lungo, il viso un po’ triste, forse non da intellettuale ma da Blue Collar di Sly, perfetto per essere un modello per giovani che in quella società non si trovavano esattamente a loro agio.
Divenne un’icona dell’azione, senza troppi retropensieri. Invece erano gli anni della Guerra Fredda in una delle sue fasi più acute (l’elezione di Reagan, quella di Andropov, ex agente del KGB, le Guerre Stellari che avrebbero potuto trasformare l’Europa in un deserto radioattivo, un tempo di forti contrasti politici anche nel nostro paese). E Rambo divenne il bersaglio di chi odiava il cinema d’azione, odiava l’America e vedeva il simbolo dell’imperialismo in questo personaggio popolare, non intellettuale, che agiva più che manifestare.
John Rambo che cerca un compagno nero che scopriamo ucciso dal cancro generato dagli agenti chimici usati in Vietnam, lo stesso che vien trattato come un vagabondo da poliziotti razzisti e violenti, quello che reagisce con violenza ma scoppia a piangere perché vuole tornare a casa. Oh, quanto dileggio sollevarono quelle lacrime virili nei suoi detrattori. Jon Voight poteva piangere in Tornando a casa ma Rambo no. Era vittima già ai tempi di quell’ossessione faziosa della correttezza politica che oggi sta uccidendo il cinema d’azione perché ne trasforma le icone in simboli di discriminazione.
Invece Rambo era un ribelle, un samurai zen, uno che faceva della sopravvivenza una fede, non essendogliene rimaste altre. Un vagabondo, un disadattato che ha evidentemente dei problemi psicologici imposti dalla società che lo ha sfruttato e poi gettato via e non gli permette di reinserirsi e lo costringe a reagire con violenza. Questo era il simbolo dell’imperialismo americano? Mah…
Una curiosità, il reduce costretto a combattere ha un antecedente illustre in Rolling Thunder con Tommy Lee Jones e William Devane di John Flynn del 1977, da non molto di nuovo disponibile nel nostro paese. Storia molto simile… ma realizzata con un viso forse non così carismatico.
È vero che nel secondo e nel terzo capitolo, basati sul personaggio ma sviluppati in altra direzione, entrarono le regole del cinema d’azione anni ’80 che, per la verità, era davvero reaganiano. Rambo combatte in Vietnam, in Afghanistan assieme ai mujaheddin (come è ironica la storia…), e spera che “stavolta la guerra gliela lascino vincere”. Più degli ufficiali russi e vietnamiti torturatori che sono obiettivamente lo stereotipo del nemico in guerra e basta, il vero avversario però è la burocrazia americana.
Charles Napier è fantastico nel secondo episodio quando trama, tradisce e inganna. Così come Martin Kove, cinico mercenario al servizio del potere. Loro sono i veri nemici di Rambo che resta un eroe ideale, fratello di tanti altri che lo hanno preceduto e lo hanno seguito. I nemici di Rambo sono quelli che stanno nella stanza dei bottoni e chiedono ad altri, a giovani che con buona pace dei detrattori ancora credono nella parola “patria” e considerano servire il proprio paese non una parolaccia ma una espressione di genuinità.
Certo, poi Rambo è una cosa che ai detrattori di tutto il genere fa montare il sangue alla testa. È un guerriero. Lo è diventato non per volontà sua e non può più farne a meno. Lo dice Trautman che pure è un personaggio ambiguo benché simpatico. Rambo deve ammettere quello che è. Non è una bella morale ma non ci sono monaci, non ci sono predicatori (come nel quarto episodio) che possano cambiarlo. È vissuto nella morte e non può fare diversamente. Un po’ perché questo è un canone dell’avventura. Un po’ perché il personaggio di Morrell questo era e questo è rimasto anche negli ultimi più aderenti capitoli.
L’eroe è contro l’ingiustizia e l’ingiustizia non ha colore politico. Esiste perché l’uomo a volte è così. Feroce. E la ferocia si combatte solo con la ferocia. È molto chiaro in John Rambo quando i membri dell’associazione cristiana pensano di poter cambiare la Birmania portando due Bibbie. All’ideale, soprattutto se è una donna a chiederglielo, Rambo alla fine un po’ cede, ma lo sa che di fronte alla barbarie c’è una sola risposta.
È la legge della narrativa e, tristemente, anche della realtà. È invecchiato, appesantito ma, alla fine, riesce quasi più convincente. Di sicuro il cinema d’azione è cambiato e anche il Rambo diretto da Sly che torna in azione malgrado l’età, è diverso. Forse più vicino al modello del romanzo originale. John Rambo torna in Indocina, scenario un po’ dimenticato ma sempre efficace. Anche lui come Willard di Apocalypse Now risale il fiume ma il suo inferno di chiama Birmania (Myanmar per dirla tutta…) e ospita uno dei regimi più feroci del mondo, di cui non si cura nessuno perché in Birmania non c’è petrolio. La storia, alla fine, è semplice. Un salvataggio di giovani idealisti (anche un po’ antipatici) operato da mercenari non sempre simpatici. Insomma nemici da tutte le parti, in primis un ferocissimo comandante birmano che gioca alla roulette con i prigionieri. Una lunghissima scena d’azione con ogni scenario possibile sotto la giungla. Sangue ed effetti speciali, riprese sincopate, rallentate, lavorate in CGI. Nel filone action più semplice e popolare un mito.
Infine Rambo torna a casa alla ricerca di chissà cosa. Lo sappiamo che la sua natura non gli concede pace. È la sua maledizione…e ora vediamo cosa succede. Senza cercare significati reconditi o messaggi, perché il cinema action negli anni ’80 come oggi è cinema viscerale, d’intrattenimento a alla fine vuole solo divertire.

Questo post rientra nel blogtour che non te lo sogni neppure.


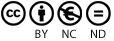













Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
