AVVISO: Il seguente articolo contiene spoilers sulla trama di alcuni film del FEFF 25
Eccoci giunt3 all’ultimo appuntamento con il FEFF 25. Partiamo dal film vincitore, presente anche nella selezione online: Abang Adik (Malaysia, 2023) di Jin Ong non solo si è aggiudicato il Golden Mulberry Award, il premio assegnato dal pubblico, ma anche il Black Dragon Award, premio speciale dato da una selezione di spettator3, nonché il Gelso Bianco, premio per l’opera prima. Un vero e proprio trionfo, insomma, anche se l’opera a mio avviso è per molti versi problematica e non pienamente convincente.
Abang e Adik sono due fratelli di etnia cinese che vivono da immigrati irregolari in Malaysia, cercando di sopravvivere come possono al rischio costante di essere scovati dalla polizia ed espulsi. Affetto da disabilità all’udito e da mutismo, Abang (Wu Kangren) cerca di affrontare la vita con stoica dedizione a un lavoro precario che potrebbe svanire da un momento all’altro. Col suo sorriso mite e apparentemente ottimista, il ragazzo cerca di illuminare le giornate con dignità e semplicità, impegnandosi a tirar sempre fuori dai guai il fratello. Adik (Jack Tan) invece, preferisce ritrovarsi in situazioni rischiose, collaborando senza farsi troppi scrupoli con alcuni criminali che sfruttano altri immigrati clandestini del Bangladesh e non disdegnando la prostituzione casuale con una donna più matura, che quasi aspirerebbe a sposare pur di poter riscattare la sua condizione di clandestino. Una soluzione alla precarietà in realtà Adik potrebbe averla sul serio, grazie alla tenacia di Jia An(Serene Lim), l’assistente socialeimpegnata a difendere i diritti degli immigrati di etnia cinese: a differenza di Abang, le cui origini restano oscure, Adik potrebbe accedere al suo certificato di nascita; basterebbe rintracciare il padre ancora vivo per far domanda di permesso di soggiorno e poi ottenere la cittadinanza. Adik, però, non ne vuole sapere, e nonostante le proteste del fratello si ostina a continuare la sua vita in fuga da tutto e tutti (verrebbe quasi da pensare che la sua fuga celi un passato di abusi compiuti dal padre, ma ciò non viene mai affermato esplicitamente nel corso della storia); ma il suo rifiuto di riallacciare il nodi del passato porterà alla tragedia. Attraverso il non detto, che aleggia soprattutto nello sguardo dolceamaro di Abang e nella rabbia di Adik, comincia a delinearsi un rapporto di fratellanza basato su una solidarietà data dalla disperazione esistenziale, piuttosto che dal legame di sangue: Abang e Adik non sono in realtà fratelli, e forse l’affetto che li lega non è neanche così autentico come potrebbe sembrare. Soprattutto, la seconda parte della vicenda ci svelerà la reale personalità di Abang, e il suo reale intento nell’approcciarsi alla vita, alla morte e al legame più importante della sua esistenza. Un evento violento e inaspettato spezza letteralmente il film in due, stravolgendone completamente gli intenti e portando i personaggi in tutt’altra direzione: da figura a tutto tondo con una sua vicenda personale profonda (il legame con il padre, l’ambizione di poter fare la differenza in una società profondamente ingiusta e indifferente), Jia An esce fulmineamente di scena, spazzata via da uno sconvolgente atto di violenza – un tentativo di stupro seguito da un omicidio. Il resto del film è consacrato da una parte alla scarnificazione emotiva di Abang, deciso ad espiare quello che a prima vista sembrerebbe essere un crimine commesso da qualcun altro, e dall’altra alla redenzione di Adik, che interpreta il gesto del fratello come un invito a voltare pagina, seppellire la rabbia e riconciliarsi con se stesso e con il padre. La doppia metamorfosi viene segnalata visivamente dall’aspetto scheletrico di Abang, che rifiuta di mangiare una volta rinchiuso in prigione perché in fondo lui non è mai appartenuto alla vita, è solo stato un ospite imprevisto nell’esistenza di qualcun altro, e dall’aspetto curato e pulito di Adik, che passa dai jeans stracciati e i capelli tinti di rosso ribelle alle camicie eleganti e una chioma naturale. Peccato che per arrivare a descrivere il cammino di redenzione di uno dei due protagonisti maschili regista e sceneggiatore abbiano voluto eliminare la donna principale presente nella storia (è forse anche per questo, come sorta di premio di consolazione, che la sceneggiatura affida un ruolo alla vicina di casa Money, donna transgender da cui spesso i due fratelli trovano rifugio ma che resta tutto sommato una presenza di contorno).

Personalmente ho trovato scioccante vedere come il femminicidio (con annesso tentativo di stupro) di una giovane ragazza che era fino a quel momento stata caratterizzata come uno dei personaggi principali passi quasi inosservato di fronte all’evoluzione interiore dei due personaggi maschili ed in particolare alla rivalsa sociale di uno di loro, a ribadire per l’ennesima volta che per potersi riscattare l’eroe deve cancellare ogni possibile “distrazione” femminile incontrata lungo il cammino. Quanti film abbiamo visto in cui sono le donne a perdere, o a essere di contorno? Non sarebbe ora di smetterla? Che addirittura il pubblico abbia voluto premiare in maniera così esagerata un film dove si compie un tale atto di cancellazione culturale e concettuale la dice lunga, se mai ce ne fosse bisogno, sullo stato in cui versano le donne in un paese come l’Italia, dove la cultura maschilista e patriarcale è talmente radicata nell’immaginario collettivo e nella cultura dominante da aver colonizzato i cervelli e l’abilità stessa di osservare certi meccanismi. Il mio, sia ben chiaro, è un discorso politico oltre che culturale: ritengo che nel fare determinate scelte su cosa e come raccontare una storia, il/la su3 autor3 faccia una scelta che è anche e soprattutto politica. Cancellare una donna dalla trama per permettere ai protagonisti maschili di fare determinate cose è una scelta politica; a quella donna eliminata e impossibilitata ad avere il controllo del proprio destino e del proprio corpo, come lo sono tante donne nella realtà (l’avanzare delle associazioni anti-scelta in Italia e in altre parti d’Europa ne sono un esempio), non è stata data nessuna possibilità di evolversi, dopo aver però dato l’illusione che anche la sua storia avesse uno spessore. Tanto valeva che Jia An non ci fosse affatto nel film, sarebbe stato più onesto. Anche volendo tralasciare questo “piccolo” particolare (ma da parte mia riesce molto difficile se non impossibile farlo), le motivazioni che spingono Abang a fare quello che fà risultano molto problematiche, ancor più perché il fratello non verrà mai a conoscenza della realtà dei fatti. La presunta redenzione di Adik, a ben vedere, si basa su una menzogna e non sull’affetto: Abang non agisce per spingere Adik a cambiare vita, bensì per senso di colpa e per disperazione. Quello che nella prima parte del film era parso come sguardo fatto di onestà e semplicità risulta invece consumato dall’inganno. Certo, Wu Kangren ci regala un’interpretazione mozzafiato, ma questo non basta a sollevare il film dalle sue implicazioni eticamente discutibili, almeno per quanto mi riguarda. Perché, fra l’altro, la persona più moralmente corrotta della storia dovrebbe meritare una redenzione? E perché, se Adik pensa di aver commesso un omicidio, non fa nulla per riscattare il nome del fratello, ma ne accetta opportunisticamente il sacrificio? Forse il regista vuole dirci che in questa società solo ai meschini è permesso di avere una seconda possibilità? Tutt3 l3 altr3, vittime involontari3 o carnefici sotterrane3, meritano solo la morte? Personalmente, ho amato molto la prima parte del film, con quel suo mescolare le vicende personali al problema sociale dell’immigrazione clandestina, e avrei preferito vedere uno sviluppo di quel filone della trama; che fine fanno ad esempio i malavitosi con cui Adik collabora o gli immigrati del Bangladesh che rischiano di essere espulsi non ci viene più detto, né ci viene detto perché Adik dovrebbe aiutare ad incastrare altri poveracci come lui clandestini e come questa contraddizione aiuti a rendere il suo personaggio complesso, disilluso e insieme squallido. Così com’è, il film finisce per diventare qualcosa di posticcio, dove il doppio sacrificio di morte (la delle quali avvenuta quasi per caso, ma non per questo meno grave e significativa della seconda) non verrà mai onorato per davvero, perché dell’impatto della morte di Jia An sulla comunità e su suo padre (che non vediamo più per tutto il resto del film) non sapremo mai nulla, e perché di quello che Abang pensasse veramente di se stesso e del fratello, Adik non lo saprà mai. Quindi questa presunta redenzione è essa stessa posticcia e fastidiosa, perché costruita letteralmente sulle ossa delle persone morte.
Più onesto nel suo prendersi poco sul serio pur dicendo cose tutto sommato profonde mi è parso il terzo classificato ai Golden Mulberry Awards, Yudo (Giappone, 2022) di Suzuki Masayuki. Alla morte del padre, l’architetto Miura Shiro (Tōma Ikuta) si ritrova a tornare suo malgrado nella cittadina di provincia da cui era scappato, per capire cosa fare dell’azienda di famiglia ancora in attivo gestita dal fratello Goro (Gaku Hamada).

Trattasi di un sento, ossia un bagno pubblico, tradizione giapponese molto in voga fino agli anni ‘70 del ventesimo secolo, salvo poi cadere in disgrazia con la diffusione dei bagni privati nelle case delle famiglie. Un tempo un lusso di poch3, infatti, il bagno era un vero e proprio luogo di ritrovo dove la comunità di quartiere poteva rilassarsi dopo una giornata di stress immergendosi nell’ampia vasca in ambienti rigorosamente divisi per genere sessuale. Al suo arrivo, Shiro s’imbatte subito nella simpatica Izumi (Hashimoto Kanna), che accoglie clienti col suo sorriso genuino e i modi semplici, per poi ritrovare il fratello, con il quale non parlava ormai da anni. All’inizio, Shiro non comprende davvero dove sia il fascino di quel mondo ormai desueto che non porta soldi ma solo fatica; soprattutto, l’atteggiamento modesto e privo di ambizioni di Goro lo infastidisce, e l’entusiasmo di Izumi nel salutare le persone gli pare esagerato per un’attività senza futuro come quella. Ammantato dallo snobismo tipico di chi crede di aver trovato il senso della vita nel successo e nel denaro (ma scopriremo che la sua carriera non è poi così brillante come vorrebbe far credere), in quanto primogenito Shiro sta già meditando sulla possibilità di vendere il sento per ricavarne degli appartamenti redditizi, ma non ha il coraggio di dirlo né a Goro né a Izumi, visto il loro inspiegabile attaccamento a quel luogo per lui un po’ inutile e demodé che loro sembrano trovare magico. Ovviamente, la permanenza prolungata nel Marukin – questo il nome del sento della famiglia Miura – farà cambiare idea a Shiro, e scoprire che la vita a volte regala epifanie inaspettate negli angoli più improbabili del passato. La bellezza maggiore del film, cosa che probabilmente lo ha fatto amare anche al pubblico del FEFF 25, è il suo essere una storia fatta di nostalgia per i piccoli piaceri della vita, narrata con leggerezza e incanto attraverso tre realtà diverse che finiscono per confluire fra loro: la prima è quella dello yudo, o via del bagno, disciplina dedita all’apprezzamento della vita e del suo scorrere lento attraverso un rigoroso esercizio di preparazione all’arte dell’immersione nella vasca e della pulizia personale, volta ad innalzare l’adept3 sia sul piano fisico che spirituale. Le sequenze in cui il maestro (Sasano Takashi) e il suo giovane assistente (Kubota Masataka) spiegano le regole dello yudo agli adepti (tutti uomini) sono forse tra le più apprezzabili del film, anche per il modo in cui il maestro fà la parodia di se stesso (memorabile ad esempio è il gioco di parole fra yudo in giapponese e you do in inglese), dimostrando come il praticare una disciplina fisica ed insieme interiore stia anche nel prendere le cose con leggerezza e senza attaccamento, consapevoli del fatto che “la felicità non si cerca, si realizza.” La vicenda della scuola di yudo, parallela alla ricerca del senso della vita compiuta da Shiro, è resa ancor più spassosa dalla presenza di un adepto un po’ speciale, Tadashi Yokoyama (Fumiyo Kohinata), un ex postino ormai in pensione che aspira ad investire i soldi della liquidazione nei lavori di rinnovo del bagno di casa, dove centrale dovrà essere la presenza di una vasca in puro legno di cipresso, il migliore per un bagno rigenerante. Il suo volto, colto da estasi mistica o segnato da rassegnata disperazione, è un vero e proprio antidoto alla schadenfreude che piaga le nostre esistenze condizionate dall’odio diffuso dalla cassa di risonanza dei social network: il suo anelito interiore ruba spesso la scena ai protagonisti della storia; la dedizione per lo yudo mostrata da Tadashi, sincera e fatta di una semplicità disarmante, strappa più di un sorriso carico di affetto. Vi è poi il celebrato mondo degli onsen, le sorgenti termali giapponesi, di cui il famigerato e temutissimo critico Ota (Yoshida Kotaro) scrive in libri e recensioni. La sua penna tagliente è in grado di distruggere la reputazione dei bagni termali con un battito di ciglia, quindi tutti temono una sua visita, perché un giudizio negativo potrebbe far chiudere i battenti alla propria attività. Queste due realtà, apparentemente agli antipodi rispetto al sento, vengono lentamente a convergere con il Marukin e i suoi personaggi pittoreschi, fra i quali spicca il misterioso “eremita dei bagni” (Emoto Akira), che parla in massime e definisce l’essenza del sento e dello stare in vasca come qualcosa di simile all’entrare dentro il sole – parole che Shiro ricorda pronunciare anche da suo padre quando era giovane. Non un capolavoro, ma sicuramente un film da vedere e apprezzare.

Concludo il mio resoconto con il film che più ho apprezzato quest’anno: Your lovely smile (Giappone, 2022) di Lim Kah-wai, mockumentary che vede protagonista il regista indipendente Hirobumi Watanabe. Deciso a voler trovare i finanziamenti per il suo nuovo film (di cui non ha ancora chiara né trama né possibili interpreti) Watanabe si ritrova a lasciare la sua nativa Otawara (dove solitamente sono ambientati i suoi film) per recarsi nell’isola di Okinawa, dove un volgare tycoon dal passato criminale (Shogen) si improvvisa produttore cinematografico, proponendogli di girare un film sulla sua vita e pontificando sull’inaugurazione di un possibile festival del cinema. Inizia così un demenziale tour de force, in cui Watanabe è ridotto al rango di “cane di compagnia”, costretto a scrivere una sceneggiatura in tre giorni e riprendere quasi tutto quello che il suo “padrone” dice e fa, salvo poi essere cacciato a malo modo perché, guess what, nella vita reale di un artista alle prese con la creatività una sceneggiatura non può essere realisticamente scritta in tre giorni, e nemmeno in una settimana. Inseguito dalle guardie del corpo inferocite dell’ex criminale, invece di tornarsene a casa e pensare al film che vorrebbe fare per davvero, visto che è a corto di idee Watanabe decide a questo punto di approfittare dell’occasione per intraprendere un viaggio in po’ speciale: perché non recarsi in alcuni cinema d’essai del Giappone per vedere se chi li gestisce sia dispost3 a proiettare i suoi film durante l’emergenza Covid19? Da intermezzo dissacrante sulla vita di un regista indipendente alle prese con l’inevitabilità del blocco creativo, il conforto rassicurante dell’ozio e la tentazione di svendersi a chiunque voglia offrirgli uno straccio di contratto anche se effimero e poco edificante, il film si trasforma piacevolmente in un atto d’amore per le sale cinematografiche indipendenti. Partendo da Beppu per finire nel gelido Hokkaido. Watanabe visita molti cinema d’essai ancora all’attivo in Giappone, celebrandone l’esistenza e ammantando la storia di una vena nostalgica e al contempo realistica. Impreziosito da interviste alle persone (fra cui diverse donne) che ancora resistono nel proporre film in sala nonostante la crescente popolarità dei servizi di streaming, Your Lovely Smile ci spiega anche in maniera impietosa e senza mezzi termini quanto sia difficile per chi cerca di fare arte con mezzi propri e senza il sostegno di grossi agenti o case di produzione potenti sopravvivere alla marea fagocitante della produttività e delle big sales. Una visione artistica più intimista, forse anche imperfetta ma anche per questo più vera o semplicemente diversa, sembra dirci Lim, diventa ogni giorno sempre più vitale. Non è un lusso, ma qualcosa di necessario e che va preservato come l’aria che respiriamo, perché è in grado di restituirci quello sguardo imprevisto, quel guizzo sorprendente ed inedito a cui non avevamo pensato e che tanta produzione di massa sta rischiando di cancellare. Le grosse piattaforme di streaming, di cui Watanabe agogna scherzosamente le attenzioni nella prima parte del film, sono in realtà ciò che sta inesorabilmente strangolando la creatività genuina e non prodotta in serie, sembra dirci Lim, e preservarne l’autenticità e la magia è forse il compito più arduo che l’arte possa avere oggi, nella sua continua mutevolezza ed evoluzione, quell’arte che nel film è incarnata dall’apparizione sempre diversa eppur così familiare di Yuri (Hirayama Hiraku), fantasma che Watanabe vede in ogni angolo del paese e che lo accompagna a passi di danza verso la rinascita. Forse l’apparizione di Yuri è l’unica vera pecca del film: il leitmotif della donna che perde la propria identità per giungere a rappresentare l’arte è un simbolo fin troppo facile, e a tratti anche un po’ offensivo – era proprio necessario che nella sua incarnazione iniziale Yuri fosse una prostituta? E poi non ne abbiamo visti abbastanza di questi cliché sulla donna ridotta al rango di musa ispiratrice? Per il resto, Your lovely smile è un piccolo gioiellino, in grado diregalarci tanti sorrisi un po’ amari all’insegna della nostalgia e di farci riflettere sul confine fra arte e produzione di massa, fra ciò che veramente vale la pena custodire e assaporare, e ciò che salta all’occhio perché reso imprescindibile da algoritmi e non da un desiderio di scoperta autentico e personale.


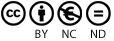





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
