Giovanni Ricciardi, giallista di lungo corso, è solito ambientare le sue storie con protagonista il commissario Ottavio Ponzetti ogni volta in un quartiere di Roma. E’ giunto così al Quartiere Giuliano-Dalmata, che prende il nome dall’ex Villaggio Giuliano-Dalmata, il Centro Raccolta Profughi sulla Laurentina, sorto nel 1947 per dare riparo agli esuli istriani, fiumani e dalmati in fuga dalla Jugoslavia di Tito. Gli edifici, diversi padiglioni contrapposti lungo un viale alberato coperto di ghiaia e collegati tra loro da due lunghe pensiline, con una fontana al centro e una chiesetta in fondo ad esso, erano stati in origine i dormitori degli operai che dovevano costruire l’E.42, l’Esposizione Universale Romana, poi interrotta a causa della guerra.
Ora, si dà il caso che il sottoscritto, all’età di tre mesi, nel luglio del 1948, arrivò, con i propri genitori e la nonna paterna esuli da Fiume, proprio a questo campo profughi, (che, tra l’altro, fa da sfondo anche al mio primo romanzo “Massacro per un presidente”, edito da Mondadori nel 1981). Ogni padiglione conteneva 11 famiglie, per un totale, nel 1956, di circa duemila persone. Per il resto era completamente isolato dal resto della città: un vero e proprio Villaggio, seppur sui generis anche per struttura, da cui poi, con lo sviluppo della città, prese nome il 32mo quartiere della capitale, diventando così l’intera zona, appunto, l’attuale Quartiere Giuliano-Dalmata. Naturalmente, nel frattempo, i padiglioni sono stati buttati giù e, al loro posto, sono sorte delle palazzine, è stata costruita una nuova, moderna e molto più grande chiesa, il viale è stato asfaltato, e la fontana è stata fatta scomparire, mentre è stata posta nei giardini dove prima c’era le vecchia chiesetta la simbolica Lupa che stava a “Pola a Roma fedele”.
A questo punto si capisce che l’interesse per il romanzo di Giovanni Ricciardi “La vendetta di Oreste” in me si moltiplica, tanto più che, dalla bandella del libro, si apprende che racconta una storia di esuli, in fuga dalla Jugoslavia di Tito.
Il fatto che Ricciardi non abiti nel quartiere e non sia un esule mi faceva temere, prima di leggerlo, sufficienza e pregiudizio. Anche perché, prima che il quartiere, in seguito alle Olimpiadi del 1960, si sviluppasse, era una realtà che, fino a circa la fine degli anni Cinquanta, ha visto noi profughi isolati rispetto a Roma, sperduti com’eravamo in mezzo alla campagna dell’agro-pontino. Realtà, per l’autore de “La vendetta di Oreste”, complicata dal fatto che i protagonisti della sua storia avrebbero vissuto proprio quegli anni e quel Villaggio così particolare – si parlava solo il veneto istriano, si festeggiavano solo i santi patroni delle nostre città di provenienza, i maestri della locale scuola erano in gran parte profughi anch’essi, per cui si viveva in una sorta di autismo sociale – una realtà, pertanto, non facile da restituire per ambiente, atmosfera, nostalgie strazianti, rapporti personali e famigliari, da parte di chi non li ha vissuti.
Ricciardi ci è riuscito? Diciamo che il Villaggio che ha descritto è l’attuale, senza più i padiglioni, ma nonostante sia il protagonista della storia, Oreste Zarotti, profugo di Pola, che sua moglie Nina, profuga da Fiume, Ricciardi li faccia arrivare al Villaggio tra il 1948 e il 1956, di quel periodo e di quella esperienza abitativo-esistenziale nel romanzo non c’è traccia.
Pertanto, Ricciardi lo descrive com’è ora, ma possiamo dire che, poi leggendo il romanzo, la cosa relativamente può bastare.
In fondo era suo compito farlo solo in parte, perché in un giallo conta il plot, la storia, e l’autore per raccontarla ha cercato di dribblare il problema del vecchio Villaggio con l’escamotage che il protagonista, Oreste Zarotti con la sua famiglia, viveva un po’ defilato rispetto al resto della comunità (anche se, date le condizioni, lo trovo molto improbabile), concentrando tutto l’interesse del lettore sullo sfondo storico che fa da prologo ed epilogo alla vicenda personale di Oreste (qualcosa ci sarebbe da dire anche sul nome, assai poco istriano) sulla quale il commissario Ponzetti indaga.
In questo senso, però, Ricciardi ha ben saputo raccontare le tragiche vicissitudini che in pratica dal 1943 al 1956 hanno caratterizzato le terre sul confine orientale d’Italia.
Innanzitutto, come entra il commissario Ponzetti in questa storia? Ci entra per amicizia prima che per dovere d’ufficio. Capita infatti che il vecchio Oreste Ponzetti muore. E il figlio scopre tra le cose quasi nascoste dal padre una pistola, una Tokarev di costruzione jugoslava a 9 colpi, carica, meno che per due pallottole. E trova una lettera che è sostanzialmente una lettera d’amore, senza data e senza firma, che apre a diversi interrogativi. A quel punto il figlio, che conosce il commissario Ponzetti per essere stato amico del padre, geometra che gli ha fatto alcuni lavori di ristrutturazione in casa, gli chiede di scoprire cosa nascondono quella pistola e quella lettera.
Ecco, tralasciando la realtà del Villaggio, che avrà nel romanzo valore solo di luogo d’ innesto della storia, Giovanni Ricciardi mette bene in evidenza, nelle tragiche controverse vicende del confine orientale italiano, appunto, le motivazioni che stanno alla base di un’epoca di cui restano solo quella pistola e quella lettera. Parliamo della fuga di tanta gente, delle identità scambiate (molti, come i miei genitori stessi, scampavano clandestinamente senza documenti, identità che più tardi venivano ricostituite davanti a un notaio a Trieste e nei centri di raccolta di prima accoglienza), di controesodi (il romanzo ricorda i 2500 operai monfalconesi che, di fronte al vuoto demografico lasciato dagli esuli, raggiunsero, su ordine del PCI, i cantieri navali di Fiume e di Pola, per far loro riprendere la produzione e, successivamente, in quanto comunisti italiani e pertanto stalinisti e, quindi, contrari a Tito, finiti tragicamente nella cayenna di Goli Otok, l’isola di sole pietre dell’Adriatico quarnerino – Goli Otok sta per “isola nuda” – dove molti di essi hanno patito inaudite sofferenze e subito la morte).
E’ in questo vespaio ideologico che affonda l’indagine di Ponzetti. E ben ci riesce l’autore a trovare il filo che rende credibile e avvincente la trama del libro, pur di fronte alla superficialità, troppo al di qua forse di quelle che volevano essere le sue intenzioni, nella restituzione del quartiere, che, a questo punto, avrebbe potuto essere uno qualunque di Roma. Ma, per il resto, plauso al giallista.


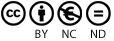

![[14] Maurizio De Giovanni](https://www.thrillermagazine.it/imgbank/thumb200/201702/21962-untitled.jpg)

















Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
