Attrice al suo esordio alla regia, la coreana Kim Do-young adatta un romanzo di successo di Cho Nam-joo che porta il nome della sua protagonista e che dà il titolo anche al film: Kim Ji-young, born 1982. Si tratta del racconto del progressivo meltdown di una donna trentenne costretta a rinunciare a se stessa per accudire gli altri: la figlia appena nata, il marito, la suocera, il resto della famiglia. Pur avendo studiato brillantemente letteratura covando il sogno di diventare scrittrice e ritrovatasi subito con un lavoro soddisfacente nel campo del marketing, Ji-young (Jung Yoo-mi) ha dovuto rinunciare sia ai sogni che alla carriera dopo la nascita della figlia e, pur senza mai dichiarare apertamente che ci sia qualcosa che non va nella sua nuova vita, la donna comincia progressivamente a manifestare segni di cedimento, stanchezza e vera e propria crisi, arrivando a “sdoppiarsi” parlando di sé in terza persona o dissociandosi per allontanare il dolore, impersonando inconsapevolmente la nonna o la madre per esternare in qualche modo la dilaniante sofferenza che la sta distruggendo. L’inesorabile deteriorarsi del vivere di Ji-young è contrassegnato da continui passaggi fra il suo presente e il suo passato, fatti di opportunità accennate e negate, discriminazione a casa e al lavoro, traumi e piccoli successi, a cui fanno da controcanto i momenti che la storia riserva al marito Dae-hyun (Gong Yoo), umanamente preoccupato per la salute di Ji-young e intenzionato a risolvere la situazione con genuina onestà, ma costantemente esposto ad ambienti e persone intrisi di pregiudizi e luoghi comuni, come i colleghi dell’ufficio o la madre. Nell’alternarsi di un passaggio nell’altro, emerge prepotente il muro invalicabile di una cultura maschilista che, vede la donna come mera decorazione e insieme entità votata al sacrificio, destinata a servire e mai ad ascoltare i propri bisogni. Sintomatico in tal senso il regalo che la suocera fa a Ji-young rimarcando come “ho fatto una fila di due ore per prenderlo”: un grembiule!

Partendo dal presupposto che “il personale è politico” (per citare un saggio di Carol Hanisch del 1970), Ji-young è assunta ad emblema della condizione di inferiorità e senza via d’uscita di tutte le donne coreane (il suo nome è infatti fra i più comuni fra i nomi femminili in Corea del Sud), e quella che potrebbe sembrare la vicenda di una singola donna si pone invece come un’opera di denuncia politica delle discriminazioni e delle tare ataviche di una società e cultura (non soltanto coreane) che non permettono alle donne di esprimere veramente se stesse se non attraverso il ruolo di madre o moglie di qualcuno, ruolo che le stesse donne (vedi la madre di Dae-hyun) spesso contribuiscono a rafforzare con la propria complicità e compiacenza verso modelli tossici che perpetrano il potere maschile.

Salutato in patria come manifesto del femminismo di inizio ventunesimo secolo, il romanzo (così come il film) ha riscosso un immenso successo di pubblico nonostante i tentativi di boicottaggio da parte di organizzazioni maschiliste e misogine coreane. Traendo ispirazione dalla sua esperienza personale di donna costretta a lottare con le possibili conseguenze della maternità sulla sua carriera cinematografica, Kim Do-young ha deciso coscientemente di riportare con forza sotto i riflettori dei media e della popolazione il dibattito sulla mancanza di spazio personale per le donne sposate e con figli, additate via via come parassite se osano riposarsi anche solo per un attimo (“Vorrei poter bere caffè e riposarmi con la busta paga di mio marito” commenta un uomo ad un certo punto vedendo Ji-young seduta mentre lui deve lavorare per guadagnarsi da vivere) o “pazze” (come sentenzia sbrigativamente un collega di Dae-hyun) se si permettono di esternare il proprio malessere davanti agli altri. In un’epoca in cui, in Corea del Sud come in Italia o altre parti del mondo, i pregiudizi culturali nei confronti delle donne sono purtroppo ancora molto alti e frequenti (lo dimostrano i troppi fenomeni di istigazione all’odio misogino sui social networks e i casi di femminicidio diffusi su scala globale), un film come questo assume un’importanza universale che ne rendono la visione illuminante per la sua immediatezza e semplicità e politica per i suoi contenuti. Kim Ji-young, born 1982 ha il pregio di saper essere un film profondo e popolare insieme, capace di porre i riflettori su questioni fondamentali e tutt’ora irrisolte che intralciano l’esistenza e la realizzazione personale, creativa e lavorativa delle donne, come ad esempio le molestie sul lavoro, il glass ceiling, l’iniqua distribuzione del lavoro di cura in famiglia, i licenziamenti o la non assunzione per il solo fatto di avere un utero e quindi potenzialmente anche una figlia o un figlio. L’aspetto più interessante del film, che lo rende incisivo e che ne fa un autentico manifesto femminista oltreché un’opera di denuncia, è la solidarietà ed empatia che Ji-young trova in diverse figure femminili, sia accidentali o secondarie (come una passeggera dell’autobus o le ex colleghe dell’ufficio) sia di primaria importanza: la sua ex responsabile in ufficio (memorabile la sua reazione al tentativo di sminuirla da parte del direttore maschio di turno che insinua “a chi importa il successo” di una donna “se non riesce a crescere un figlio”, o forse, se comanda, allora “sarebbe dovuta nascere uomo, giusto?”), la sorella Hye-Soo (Lee Bong-ryeon) o la madre Mi-sook (una straordinaria Kim Mi-kyung). Donne non comuni, che incarnano la possibilità di un ruolo non passivo e diverso per le donne nella società e nella cultura e che danno nuova linfa vitale a Ji-young, permettendole di riscattarsi grazie anche al ritrovamento della propria autentica voce.



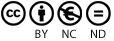





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
