Un fulmine improvviso attraversa con la sua onda d’urto la scuola d’arte Tak Sing School: uno studente è stato ritrovato a terra accoltellato ed è morto, altri due, feriti gravi, sono in rianimazione, mentre un quarto, probabilmente autore del crimine, è scomparso. I giornalisti piombano immediatamente addosso alle persone e ai luoghi coinvolti dall’evento, lanciando le loro sonde fameliche sulle famiglie armati di microfoni, cellulari, macchine fotografiche e domande gracchianti, pronti ad estrarre la verità dai volti doloranti in un turbinio di urla, scatti, ipotesi di moventi e analisi psicologiche. E intanto, mentre gli insegnanti cercano di allontanare l’ombra oscura della morte dalle giornate dei ragazzi in modo che “la tragedia non disturbi i vostri studi”, ben presto alle fameliche richieste dei giornalisti fa eco la reazione a catena generata dall’instant messaging telefonico che studentesse e studenti imbastiscono dimenticandosi completamente della lezione. I loro messaggi concitati e concatenati formano così gli anelli di una narrazione compatta e unanime sui retroscena e le motivazioni che hanno portato al delitto, confermandone la validità assoluta e incontestabile durante gli interrogatori con la polizia: Gangzi (Hon Kahoe), la vittima, era un ragazzo di umili origini e per questo considerato come un essere inferiore dal ragazzo scomparso, Chen (Fu Xianjun), bambino viziato e altezzoso che snobbava tutti tenendoli sempre a distanza. Motivo principale della discordia fra i due era Xu Qianmo (Wilson Hsu), una ragazza da poco trasferitasi nella scuola che flirtava con entrambi e che, essendo già stata espulsa dall’istituto precedente per aver adescato il suo istruttore di danza, doveva chiaramente avere un appetito sessuale fuori della norma. A completare il quadro delineato con decisione da mass media e studenti, il ritratto pubblico delle due madri: da una parte Gu (Remon Lim), la madre di Gangzi, umile massaggiatrice dall’aspetto dimesso e segnato da una vita di stenti, esempio di grande devozione e responsabilità per aver sacrificato tutto in modo da far studiare il figlio appassionato di disegno in una scuola prestigiosa; dall’altra Mei (Lu Huang), elegante e ricca CEO di una compagnia di videogiochi violenti, madre discutibile che, oltre ad essere figlia di immigrati e quindi non certo una cittadina di prima scelta, ha persino cresciuto il figlio senza un uomo al suo fianco, lasciandolo quindi spesso da solo e probabilmente permettendo che quei giochi violenti avessero un’influenza indelebile su di lui, fino alla tragedia.

La storia è già stata scritta nei suoi minimi dettagli quando Chen decide di riapparire all’improvviso per confessare il suo crimine: tutti esultano, sicuri che giustizia verrà fatta; c’è anche chi organizza un crowdfunding per aiutare Gu a pagare le spese dell’avvocato o chi, scoperto che Chen non verrà condannato all’ergastolo perché minorenne, organizza una petizione per rovesciare il verdetto del tribunale. Di fronte a una verità così lampante, Gu non può che odiare Mei e il destino che le ha sottratto il figlio, rifiutandosi di accettare i gesti di empatia che l’altra donna accenna verso di lei per smarrimento o forse per semplice umanità, perché nel mondo in bianco e nero della narrazione mediatica di cui sia la legge che i rapporti umani non possono non tener conto, vittime e carnefici si escludono a vicenda senza mai confondersi fra loro. Ma basteranno due oggetti scoperti per caso da Gu nella stanza di Gangzi perché questa narrazione manicheista, così apparentemente granitica e incrollabile, si sfaldi per dare inizio a una narrazione altra, ed è qui, dopo la giostra frenetica iniziale, che la storia vera e propria comincia, in un affastellarsi di verità molteplici tenute costantemente soffocate per crudeltà, paura, sottomissione, negazione della vera natura di sé e di chi ci è affianco, in un gioco al massacro che non può avere alcuna boccata di ossigeno se non nella violenza e nella morte.
Intenso e potente nel descrivere la brutale e inevitabile discesa nell’inferno del bullismo di due ragazzi incapaci di dire no alle regole del branco, Victim(s) s’interroga su come la mancanza di accettazione di sé da una parte e il non poter (o non voler) reagire ai soprusi per mancanza di fiducia nel sistema e forse anche in se stessi dall’altra possa portare gli adolescenti a compiere delle scelte irreversibili che, pur volte ad allontanare e possibilmente cancellare il dolore dato dalla propria condizione di vittima, finiscono per amplificarlo. Sta proprio qui il significato di quella s fra parentesi del titolo inglese del film: nel propagarsi del ruolo di vittima da un personaggio all’altro, arrivando a coinvolgere sia Gangzi che Chen e uccidendoli entrambi in maniera differente, realmente o metaforicamente. Ma l’aspetto ancor più interessante del film è probabilmente l’ampiezza di quel propagarsi del contrassegno plurale, coinvolgendo nella condizione di vittima anche le due madri Gu e Mei, entrambe all’oscuro della vera vita dei propri figli ed entrambe ridotte a meri bersagli della discriminazione insensata da parte della cultura maschilista dominante: mentre Gu, abbandonata dal padre di Gangzi, si ritrova costretta a convivere con un alcolista violento per poter sopravvivere ma che poi lo vede fuggire via con i pochi soldi da lei messi da parte per la retta scolastica del figlio visto che “lui è morto, noi dobbiamo vivere”, Mei deve continuamente fare i conti con una società che non la accetterà mai e la bollerà sempre come inadeguata perché immigrata, single, colpevolmente ricca e di successo. E, unica presenza consapevole di sé e di quanto inutile la verità possa essere, ad emergere nella sua purezza disperata la fiera Qianmo, travolta dagli eventi nonostante sia la sola in grado di leggere chiaramente la realtà cercando di opporvisi con le sole armi che conosce: la solitudine, il rifiuto del branco e della sua verità preconfezionata, ma anche l’accettare stoicamente la fine dei propri sogni perché il mondo glieli ha strappati via, e continuerà sempre a farlo perché le donne, soprattutto se giovani e carine, finiscono comunque per essere additate come carnefici, per tutti colpevoli e provocatorie e dunque ridotte a oggetti da esibire, torturare, cancellare, vittime per eccellenza in un mondo che non le contempla e ne deturpa la fame di danza, complicità, amicizia, forse anche amore. Il suo volto, le sue mani, i suoi passi finali di rassegnazione mista a resurrezione, dolcezza mista a tristezza, ci lasciano in regalo un segno di soffocata liberazione, un arco di speranza reso possibile dalla volontà di voler spezzare quel cerchio ambiguo di ruoli sovrapposti di vittima e carnefice che tante, troppe volte rovinano la vita delle persone, e soprattutto delle donne. Il titolo originale cinese del film pone infatti volutamente l’accento sia sulla specularità e accostamento dei due ruoli di vittima e carnefice che sul loro reciproco combattersi: Jiahai zhe, Beihai ren 加害者,被害人 (che può essere reso sia al singolare come “Carnefice contro/e Vittima” che al plurale come “Carnefici contro/e Vittime”) sembra sottolineare un non volersi arrendere alla macronarrazione di disparità di genere e di orientamento sessuale imposta, in Asia come in altri continenti, da governi, società e da mass media, spingendoci a mettere in discussione pratiche culturali tossiche e nocive che, con la scusa di dover dimostrare di “essere un vero uomo”, spingono i ragazzi ad assumere comportamenti violenti nei confronti di se stessi, degli altri ragazzi e delle ragazze.

Presentato alla ventiduesima edizione del far East Film Festival di Udine e in concorso come opera prima della regista e sceneggiatrice cinese Layla Zhuqing Ji (anche se il film, seppur recitato quasi esclusivamente in mandarino, era ufficialmente in concorso come opera malese, e si può dedurre un’ambientazione non cinese dai pochi personaggi secondari che non parlano mandarino, come la guardia carceraria), Victim(s) è anche un canto di inaspettata (e disperata) solidarietà femminile di fronte alla debolezza e alla crudeltà maschile, una danza struggente recitata con grande intensità (notevoli Wilson Hsu, Fu Xianjun e Remon Lim) e diretta in modo magistrale. Un’opera necessaria e incisiva, che lascia sperare per il futuro creativo della sua autrice e che avrebbe meritato qualcosa di più di un semplice secondo posto. Sicuramente, uno dei film più belli del FEFF 22 e consigliato senza esitazioni.



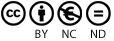





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
