Visibile e multiforme come un paesaggio, la vita di una singola persona può a volte apparire sfocata se osservata con le lenti della consuetudine: incastonate fra la purezza del silenzio e i suoni eccentrici dell’alterità, alcune esistenze tendono a rimanere fuori dalla scena, invisibili perché forse incomprensibili.
Da questo piccolo assunto sullo scarto esistente fra sé e il resto del mondo muove i suoi passi Ito (Komai Ren), la protagonista del film omonimo di Yokohama Satoko. Solitaria adolescente più avvezza a parlare il dialetto tsugaru della sua zona d’origine che la lingua giapponese standard, Ito è anche l’ultima depositaria di un’importante tradizione di famiglia: come la nonna (Yoko Nishikawa, musicista professionista nella realtà) e la madre ormai morta da tempo, è un’abile suonatrice di shamisen, strumento musicale a tre corde tipico della prefettura di Aomori, dove è ambientata la storia.
Chiusa nel suo mondo fatto di silenzi, contatti appena sfiorati con le altre persone ̶ incluso il padre Koichi (Toyokawa Etsushi), docente universitario di Tokyo ̶ e ricordi vaghi della madre persa all’età di cinque anni, Ito vive un rifiuto della propria alterità caratterizzata sia dall’appartenenza a una minoranza linguistica (che le comporta difficoltà a pronunciare le parole nella lingua standard) sia dall’abilità nel suonare uno strumento musicale insolito. Ai suoi occhi, entrambe le sue peculiarità la rendono inadeguata allo stare al mondo: trascurare la pratica con lo shamisen diventa dunque la sua forma di ribellione contro una vita senza via di uscita, con un padre che non la capisce (letteralmente, visto che essendo di Tokyo non parla il dialetto tsugaru) e una nonna che, costringendola ad esercitarsi sullo strumento, la riporta involontariamente alla memoria di un passato traumatico. Soprattutto, Ito ritiene che per trovare “il proprio suono” debba allontanarsi dalla famiglia e da quello strumento cucitole addosso come vocazione implicita, così, complice l’annuncio di un lavoro part-time, decide di diventare cameriera in un maid café di Hirosaki.
Pratica ben radicata nel settore dell’intrattenimento giapponese contemporaneo, il maid café è una tipologia di bar-caffetteria caratterizzata da una spiccata reificazione delle cameriere, avvolte da abiti iper-sessualizzanti in stile vittoriano e totalmente devote ai loro clienti, salutati con l’epiteto di “padroni” (sebbene lo stesso trattamento venga riservato alle clienti donne, salutate come “padrone”, il target implicito verso il quale le ragazze rivolgono la propria attenzione è il cliente di sesso maschile).

Nonostante le implicazioni palesemente degradanti che un lavoro del genere possa comportare per una ragazza, il maid café di Hirosaki costituisce una realtà eccentrica rispetto agli standard di Tokyo: qui non vi sono cameriere ridotte a corpi iper-sessualizzati e poco vestiti, ma donne in comode divise dai vaghi richiami vittoriani, un servizio spartano e slogan di accoglienza un po’ sommari ispirati alle norme di etichetta della servitù britannica ottocentesca. Insomma, più un luogo di “combattimento” per chi cerca di sbarcare il lunario come può che non un piegarsi alla cultura maschilista dominante.
Lontana dagli sguardi e dal giudizio del mondo (e significativamente celata dietro un’uniforme che la rende potenzialmente invisibile), in questo nuovo luogo Ito sembra trovare un piccolo rifugio contro l’incomunicabilità e la barriera delle parole, grazie anche alla presenza delle sue nuove e combattive colleghe, tutt’altro che servili o assoggettate al maschio di turno: Sachiko (Kurokawa Mei), ragazza madre ultratrentenne, ha trovato nel bar l’unica chance di sostentamento dopo essere stata stigmatizzata dalle altre ditte per via della sua condizione di donna sola con figlia a carico, ancora poco accettata dalla società giapponese, mentre Tomomi (Mayu Yokota), aspirante mangaka che lavora sodo per mettere soldi da parte e iscriversi all’accademia, è abilissima nel protestare contro le molestie dei clienti, difendendo Ito quando è necessario e aprendole gli occhi sulle discriminazioni che le donne subiscono quotidianamente a causa della cultura dominante maschilista. È proprio questa cultura a far sì che gli avventori del maid café si sentano indistintamente in diritto di palpare le cameriere in quanto “oggetti” a loro disposizione e di autoproclamarsi “paladini” della giustizia, proponendo a tutti i “padroni” di indossare guanti che “attutiscano” l’effetto della molestia ̶ di fatto riducendo la molestia a un “innocuo” gioco erotico che ne cancella completamente il contenuto violento cancellando il dolore della donna che ha subito il trauma.
Il ritrovarsi lei stessa vittima di un abuso improvviso da parte di un “padrone” nel luogo che ha scelto come rifugio pone improvvisamente Ito di fronte allo strappo esistenziale che si porta dentro, e che pensava di poter occultare voltando le spalle a tutto. Nella sua ricerca di una via capace di comunicare se stessa fra gli interstizi dell’invisibile, lo strappo emerge improvvisamente quale cifra del suo stare al mondo, ferita sommersa che la riporta fra le braccia dell’unica vera voce che possiede: lo shamisen. Tornata a casa dopo la molestia subita, Ito riprende in mano lo strumento e comincia a suonare per lasciar parlare la rabbia, finché la pelle dello shamisen non cede, rompendosi. Il filo che la teneva precariamente in bilico tra un presente incerto e un passato ingombrante sembra spezzarsi, ma le parole della nonna giungono a scuotere quello strappo e a trasformarlo in un sussulto, quasi un’illuminazione: “lo shamisen è arrabbiato con te”. La mancanza di esercizio ha causato la rottura dello strumento, e se Ito vuole davvero dare corpo alla propria voce dovrà ripararlo con i propri soldi, visto che la pelle per creare uno shamisen è molto costosa. Forse, lo strappo ormai diventato doppio nel cuore e nello strumento permetterà a Ito di trovare una via tutta sua verso l’autodeterminazione, un solco simile a quello creato dalle corde dello shamisen sulle unghie grazie alla pratica paziente e costante ̶ itomichi (糸道いとみち), che è anche il titolo originale del film ̶ che possa far vibrare le note acute della sua anima rendendole limpide anche agli occhi delle altre persone.

Ispirato all’omonimo romanzo di Koshigaya Osamu, Ito è una delle opere più belle mostrate al FEFF 23, capace di raccontare il percorso di una ragazza verso la narrazione di sé attraverso l’assenza di parole e la frattura creatasi fra lei, il padre e la nonna, tutti emotivamente mutilati da una morte passata ma indelebile che fingono di non vedere e che ha effetti devastanti sul reciproco tentativo di dialogo. Soprattutto, lo scontro continuo fra Ito e il padre Koichi mette in scena due modi differenti ma tra loro complementari di vedere la realtà attraverso i quali Yokohama Satoko infonde uno sguardo politico di genere molto incisivo alla sua storia. Illuminante in tal senso è uno dei dialoghi chiave del film, che mette a confronto due visioni dell’empowerment femminile: da una parte, c’è l’analisi socio-culturale di Koichi (“siamo nel 2020; le donne non devono strisciare davanti agli uomini. Non siete dei cani”), a sottolineare come la scelta di Ito di lavorare in un maid café sia tutt’altro che gratificante; dall’altra, c’è il grido disperato di Ito (“non riesci a sentire il mio silenzio!”), che trova il discorso del padre offensivo perché incapace di vedere quello che lei sta facendo per davvero ̶ trovare la sua strada, con dignità. Lo scarto fra le due visioni è, ancora una volta, letterale, visto che Koichi il maid café di Hirosaki non l’ha mai visitato e può dunque vedere la scelta della figlia solo attraverso la lente opaca del pregiudizio, in un sterile esercizio a priori che di fatto lo rende cieco di fronte all’evoluzione di Ito. Ma, ed è forse questo il messaggio più toccante e più bello del film di Yokohama, per essere in grado di vedere veramente chi abbiamo di fronte bisogna imparare ad ascoltare il suo alito invisibile, quel paesaggio interiore e infinito che è insieme apertura e abbraccio fra sé e il mondo.


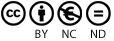





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
