Diretto da Akiko Ohku, (già regista di Tremble all you want), My sweet grappa remedies dà voce ai pensieri casuali di Yoshiko (Yasuko Matsuyuki), donna quarantenne single e senza legami significativi che decide di tenere un diario fatto di impermanenza e sussulti appena accennati, idee “che nessuno leggerà né io mai rileggerò” tracciate quasi sottovoce, in bilico fra la commozione per le piccole scoperte quotidiane e la ricerca di una direzione da dare a se stessa e a quanto la circonda. Con la sua presenza leggiadra e greve allo stesso tempo, Yoshiko passeggia per Tokyo commuovendosi e scoppiando interiormente per le istantanee che i giorni le offrono: il ritrovamento della propria bici, finita “in prigione” perché parcheggiata in un luogo non consentito ma subito riabbracciata con allegria; un uomo che borbotta da solo per strada e che poi si mette a cantare, a cui unirsi in conversazione prima dentro di sé, poi accompagnandone il canto ad alta voce. Ma, oltre che dalla casualità di eventi-stupore, la vita di Yoshiko è anche scandita da rituali ben precisi, alcuni a cadenza annuale, come andare a incontrare il mare di notte “per sentire se sono tutt’ora ancorata alla vita oppure no”, altri a cadenza giornaliera, come bere alcool ogni sera (fra cui appunto la grappa del titolo), perché è convinta che ciò possa aiutarla ad esprimere un maggiore livello di verità nei suoi sentimenti. Forse, nel suo misto di stupore e rituale quotidiano, Yoshiko sta cercando un cambiamento, ma sembra non essere veramente convinta né intenzionata ad accogliere l’inaspettato. Ma quando la collega di vent’anni più giovane Wakabayashi (Haru Kuroki) la invita ad uscire a bere qualcosa e successivamente la aiuta a conoscere Okamoto (Hiroya Shimizu), anche lui di vent’anni più giovane e incontrato casualmente davanti all’ufficio, qualcosa forse cambierà per davvero nella vita di Yoshiko, costringendola a fare i conti con la presenza delle altre persone e con il provare vero dolore o vera gioia per loro, con loro e verso se stessa.

Piano piano, dietro un’apparente leggerezza priva di intenzione, vediamo emergere il ritratto di una donna compressa in una bolla di afasia emotiva, incapace di accettare ciò che può essere e diventare o di lasciarsi contagiare dagli altri come da un virus benefico. Il suo scrivere, che non vediamo ma piuttosto ascoltiamo come una sussurrata sinfonia, è quasi un nascondersi a se stessa e agli altri, un prendere le distanze da quanto può affiorare sulle labbra e nel cuore ma che Yoshiko non riesce a pronunciare, preferendo fuggire. Nel suo rapporto con il mondo esterno, ma anche e soprattutto nel suo rapportarsi improvviso e inaspettato con Wakabayashi che Okamoto (entrambi significativamente indicati sempre e soltanto per cognome nel corso di tutto il film, nonostante la crescente e preoccupante vitalità che entrambi le causano), Yoshiko è come raggelata, persa di fronte alla lama oscillante fra la necessità/incapacità di comunicare con gli altri, ciò che rende il respiro dell’esistenza perennemente difficile ma unico e palpitante nella sua inevitabile verità, la sola cosa che valga la pena cercare per saper trovare se stessa.

Con un visibile sguardo di genere impresso sulla realtà e sulle cose dell’anima, Akiko Ohku ci regala un film che è un’esplorazione onesta, semplice ma al tempo stesso poetica, delle paure e dei dubbi che affollano la mente di molte donne di mezza età single e senza figli per scelta ma inconsciamente prede dei condizionamenti culturali che le spingono a sentirsi incomplete e inclini al rimpianto per ciò che non è stato o potrebbe essere. Forse proprio come forma di antidoto a questi condizionamenti, My sweet grappa remedies si rivela essere anche e soprattutto un invito ad accogliere e nutrire la vita (o più propriamente quella che comunemente chiamiamo “felicità”) nel mondo contemporaneo, nonostante esso sia caratterizzato da frammentarietà, stordimento e affollamento nei sensi, nel lavoro, nel divertimento e nell’interazione con l’Altro, per cui capire cosa si sente e cosa si vuole risulta estremamente difficile per le continue interferenze e abbracciare la vita può di conseguenza essere un processo molto doloroso per alcune persone che, semplicemente, o non riescono o si rifiutano di stare al passo con la furia devastante del ventunesimo secolo. Forse con il suo film, Ohku vuole dirci che in Giappone più che altrove le donne in particolare reagiscono alla confusione contemporanea votandosi al silenzio e all’implosione del sé quotidiano, vivendo perennemente in punta di piedi e quasi chiedendo scusa per il solo fatto di esistere, sentendosi perennemente inadeguate e fuori posto in una società che probabilmente non le capisce, non le accoglie o non le contempla affatto come soggette pensanti. In realtà, credo che la potenza di questo film sia nella sua portata universale, perché la solitudine e l’insostenibile difficoltà del mescolarsi agli altri e accettare di lasciarsi contaminare dalla loro bellezza (e dalla propria) sono indubbiamente parte del mal di vivere del nostro tempo a tutte le latitudini. Un film da abbracciare e accogliere senza chiedere certezze, guardandolo con lo stesso sguardo interiore di Yoshiko nello scrivere il proprio diario senza rileggerlo: come un atto liberatorio e insieme umile, uno scorrere nelle parole (e nelle immagini) nell’atto stesso di dirle, scriverle, mostrarle, e lasciarle andare, abbandonandosi a ciò che arriva, alla grappa ma anche alle lacrime. E insieme a Yoshiko, così facendo, possiamo imparare ad abbandonarci all’amore e all’amicizia con leggerezza, senza dar loro un significato ulteriore, senza chiedere, soltanto accettando il loro esistere. Credo che questo sia il dono più bello che un film possa farci: riallacciarci al gioco della vita e alla sua continua improvvisazione, lasciandoci sorprendere dal nostro sguardo sulle cose di cui stupidamente perdiamo coscienza ogni giorno, chiudendoci all’inaspettato che è in noi e che attende solo di essere visto.



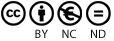





Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
